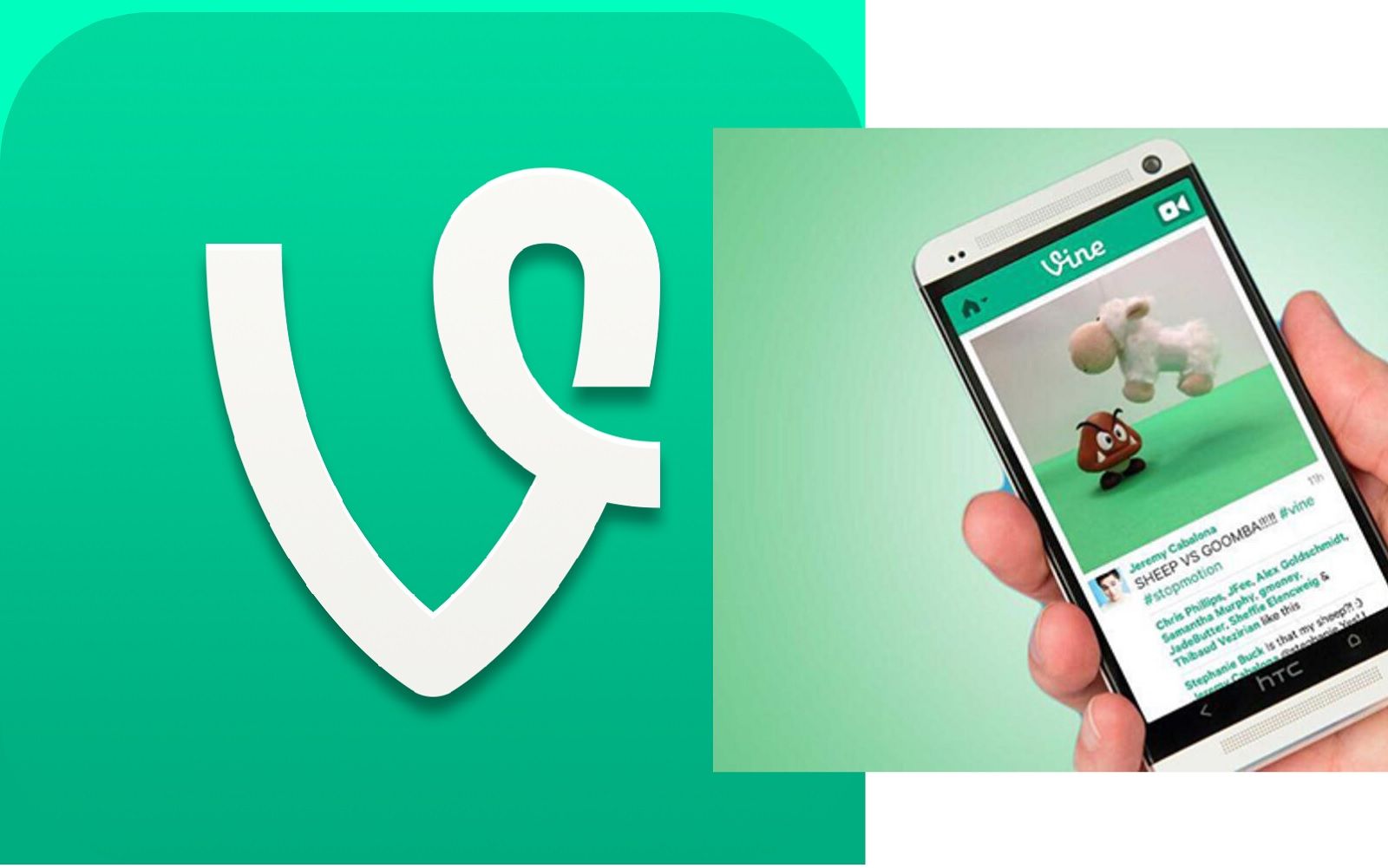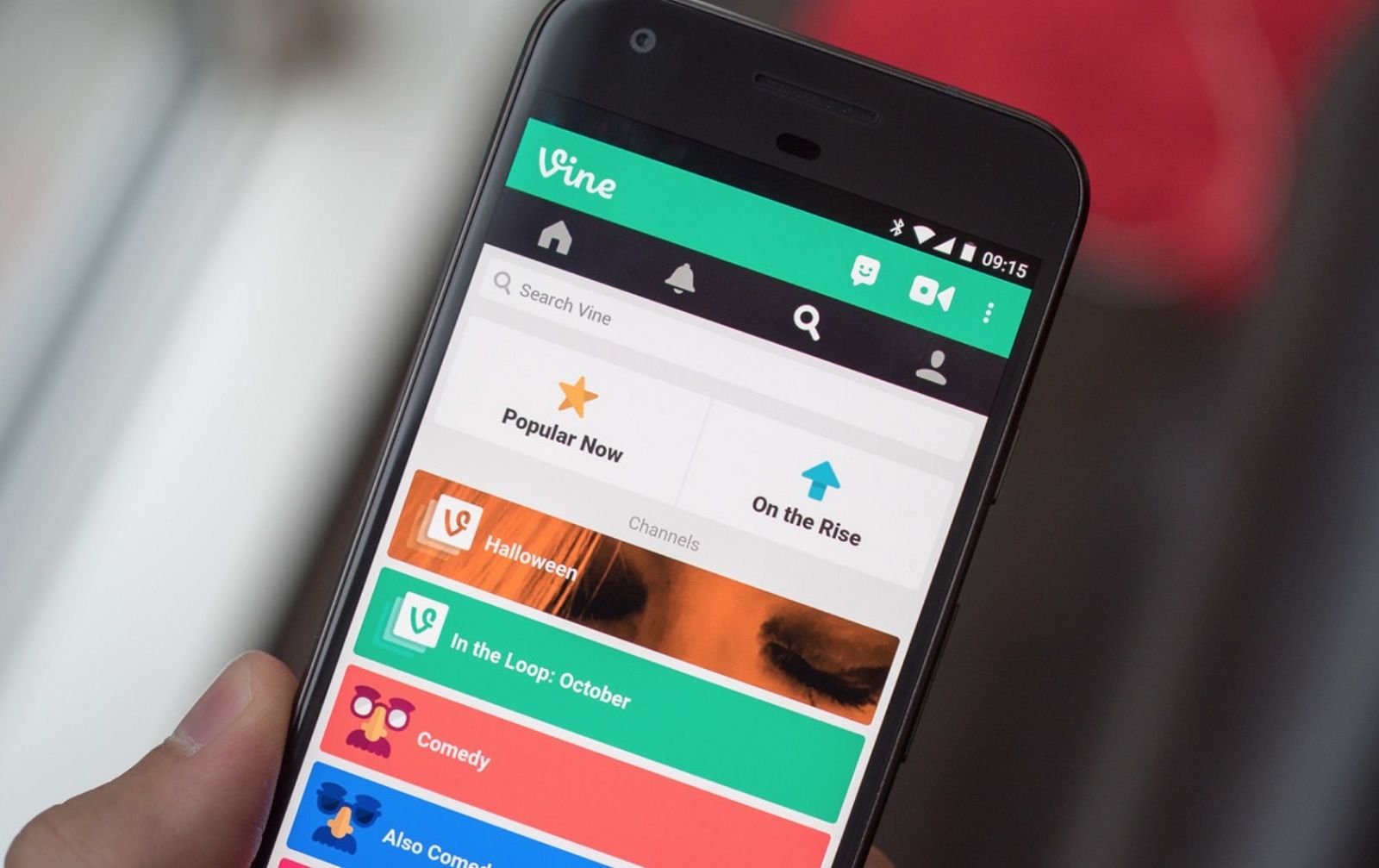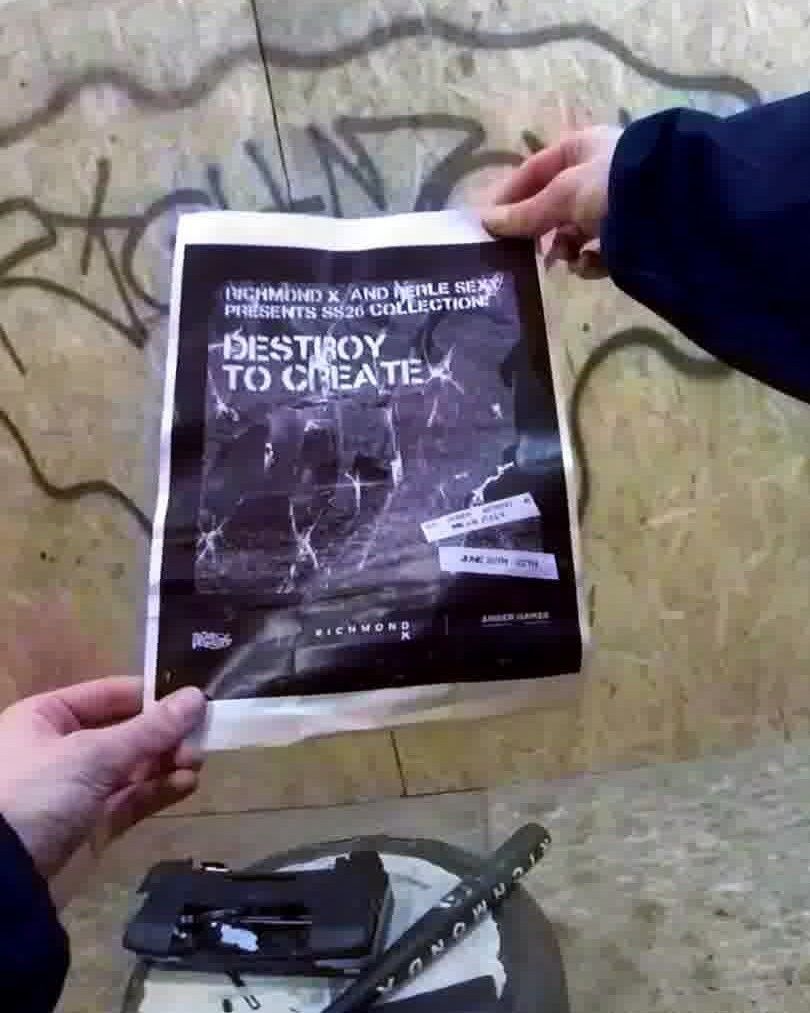10 brand scomparsi nell’ultimo decennio Da GURU a American Apparel, da Vine a Forever 21 sono tanti i marchi che tra il 2010 e il 2019 ci hanno detto addio
Sono tanti i brand che ci hanno detto addio nell’ultimo decennio. Qualcuno la chiama la morte di catene come Forever 21 o American Apparel "l'apocalisse del retail". La semplice verità è che i gusti e le mode cambiano, le tecnologie evolvono e quello che ci faceva impazzire fino a poco tempo fa oggi risulta spesso obsoleto. Difficile spiegare a qualcuno cresciuto a pane e Netflix cosa significasse stare un’ora a sbirciare tra gli scaffali di Blockbuster e poi tornare a casa col film più brutto disponibile o convincere un fan di Off-White della coolness degli skinny jeans di Cheap Monday.
Preparati i fazzoletti perché nss vi porta nel “cimitero” dei brand defunti tra il 2010 e il 2019: alcuni falliti, altri falliti e già resuscitati e altri ancora vivi, ma per poco.
Cheap Monday
Kasabian, Arctic Monkeys, The Strokes, The Kooks, Franz Ferdinand, Kaiser Chiefs,…sopra e sotto il palco dei concerti indie più cool del pianeta tutti indossavano gli skinny jean di Cheap Monday. Ora che la musica indie e il punk rock sono stati sorpassatati dal rap, anche la moda è cambiata. Basta denim super attillato, ora è il turno di volumi più over e tessuti tecnici. Il brand con il teschio fondato nel 2000 dallo svedese Örjan Andersson e comprato nel 2010 dal gruppo H&M non è più un punto di riferimento per la cultura giovanile. Fino a poco tempo fa distribuito in 1800 negozi sparsi per 35 paesi del mondo, non vende più e il colosso scandinavo ha deciso di chiuderlo per sempre nel giugno 2019, segnando la fine di un’epoca e di una delle estetiche più amate degli ultimi anni.
Vine
A Vine dobbiamo Cameron Dallas e Shawn Mendes, ma ormai non se lo ricorda più nessuno. L’applicazione creata da Dom Hofmann, Rus Yusupov e Colin Kroll e poi comprata da Twitter nel 2012 per fare e condividere video della durata di non più di 6 secondi è stata sorpassata da social che raggiungono un pubblico più ampio, come Snapchat o Instagram. Duecento milioni di utenti al giorno nel nuovo mondo non bastavano agli investitori che hanno deciso di chiudere Vine nel 2016.
Forever 21
La storia di Forever 21 è l’incarnazione del sogno americano. I coniugi Do Won Chang e Jin Sook Chang, emigrati negli USA dalla Corea del Sud, lavorano sodo e risparmiano fino a quando il 21 aprile 1984 riescono ad aprire un negozio chiamato Fashion 21 che presto diventerà Forever 21. Il successo immediato, esploso soprattutto nei 90s, è merito di una formula piuttosto semplice: seguire i trend del momento, spesso copiando più o meno spudoratamente linee, colori e tagli delle collezioni di moda più popolari (diverse negli anni le sono le accuse di plagio, l’ultima da parte di Ariana Grande). I tempi cambiano, così come il gusto nel vestire delle nuove generazioni sempre più alla ricerca di prodotti originali, unici e sostenibili, caratteristiche lontane dalla filosofia di Forever 21 che inizia una parabola discendente. Quest’anno l’azienda ha chiuso 178 punti vendita negli Stati Uniti e 350 a livello globale ed ha annunciato di aver presentato la richiesta per il Chapter 11, previsto dalla legge fallimentare federale, che consente alle imprese che lo utilizzano una ristrutturazione finanziaria.
American Apparel
Normcore, soft porn, made in USA. Sono questi i tre aggettivi che meglio descrivono quello che era il brand fondato da Dov Charney nel 1989. La label che per un ventennio ha sfornato gli outfit basic per l’hipster è rimasta soffocata da spese fuori controllo, pianificazione poco lungimirante, troppi scandali (che hanno portato anche al licenziamenti di Charney) e, ovviamente, dal naturale cambiamento delle tendenze estetiche. American Apparel ha dichiarato il fallimento nel 2017 ed è stata acquistata dalla compagnia canadese Gildan Activewear per la cifra di 66 milioni di dollari che, recentemente ha tentato il suo rilancio on line con una nuova immagine nel segno della parità dei sessi. Quasi contemporaneamente, Charney ha aperto That’s Los Angeles by Dov Charney, nuova linea di abbigliamento concentrata, ancora una volta, su capi basici maschili e femminili interamente Made in America. Cosa resta della vera American Apparel oggi? Il ricordo delle sue campagne provocatorie, un mix di immagini voyeristiche, atmosfere soft porno, t-shirt, leggings e felpe ultra minimali e colorate.
Abercrombie & Fitch
Addio oscurità, musica a volume altissimo e inconfondibile profumo che aleggia negli store e impregna anche i vestiti. Se tra gli anni ’90 e l’inizio anni 2000, Abercrombie & Fitch, con i suoi modelli rigorosamente a torso nudo e in infradito anche d’inverno, era una delle fisse per ogni adolescente con una passione per polo e i suoi abiti succinti (al centro di polemiche nel 2006 a causa delle taglie troppo piccole, ma anche per diverse accuse di discriminazione), ora non è più così. Il brand fondato nel 1892 a Manhattan da David Abercrombie non è più di moda e nemmeno la sua estetica alla Paris Hilton, così lontana dai gusti di Gen Z e millenials. Risultato? Niente più perenne fila di persone che attendono il loro turno per entrare. Gli store chiudono uno dopo l’altro, ma l’azienda non si arrende e cerca ancora di risollevare le sue sorti puntando su capi meno preppy.
Blockbuster
Il 19 Ottobre del 1985 aprì il primo store Blockbuster a Dallas, in Texas, il penultimo rimasto che si trovava in Australia, ha smesso di noleggiare DVD e videocassette nell’autunno 2019. Ora a ricordarci un epoca di confenzioni di pop corn giganti e film da restituire in tempo per non pagare una multa resta solo quello di Bend, in Oregon, stretto tra un negozio che vende cannabis legale e un crematorio per animali. Inutile dire che con l’arrivo di tv via cavo, streaming e Netflix le cassette della catena americana sono diventate obsolete.
Una curiosità: con il termine Blockbuster, durante la guerra, ci si riferiva alle bombe aeree di grandi dimensioni in grado di distruggere un intero isolato. Poi è stato utilizzato per indicare un evento, come uno spettacolo teatrale o film, di incredibile successo e capace di far saltare via (to bust) i concorrenti. E, infine, è diventato una catena di noleggio video e dvd, 8mila videocassette e 6500 titoli messi a disposizione di chiunque volesse passare qualche ora in relax davanti allo schermo.
Quiksilver
Quiksilver Inc., proprietaria di marchi come Quiksilver, Roxy e DC Shoes, è stata fondata nel 1969, ma ha toccato il vertice di popolarità negli anni ’90 grazie soprattutto a testimonial molto popolari come il surfista Kelly Slater e lo skateboarder Tony Hawk e a un’alta qualità dei suoi prodotti. Prima ad usare le chiusure a velcro e un cotone con un’asciugatura molto rapida, l’azienda era il sogno di ogni adolescente con un una passione per gli sport da tavola. Almeno fino al settembre 2015, quando Quiksilver, sorpassato da altri brand più aggressivi, è entrato sotto la protezione del Chapter 11 della legge fallimentare degli Stati Uniti ovvero lo strumento a disposizione dell’imprenditore in crisi, che permette di evitare la dichiarazione di fallimento. Poco dopo, il marchio è stato rilevato dalla società Oaktree Capital Management con un finanziamento di 175 milioni di dollari (circa 157 milioni di euro). Oggi, Quiksilver, Inc. ha modificato la propria denominazione sociale in Boardriders, Inc. che abbraccia una gamma completa dei brand iconici degli action sport compreso Billabong ed è in ristrutturazione e crescita.
John Richmond
John Richmond è tornato a sfilare nel 2017. L’avventura del brand fondato dal designer britannico nel 1987 si era arenata nel 2015, dopo la separazione con Saverio Moschillo. La rottura tra il creativo e l’imprenditore che con la sua Farlber Confezioni di Forlì produceva e distribuiva le collezioni è stata seguita da una lunga battaglia legale, finita due anni dopo. Oggi il brand, supportato da Blue Skye Investment Group, cerca di riaffermarsi tra i protagonisti delle passerelle sempre con la stessa attitude glam rock che l’ha reso famoso.
GURU
Nei primi anni 2000 le t-shirt con la margherita erano ovunque e oggi una società di Lugano è pronta a riconquistare l’attenzione persa nel 2008 dopo l'arresto per bancarotta fraudolenta del fondatore Matteo Cambi. Il successo di un tempo sembra, però, troppo lontano. Cambi riuscì a portare GURU a vertici miliardari grazie ad un mix di fortuna e intraprendenza che si intrecciavano con un’estetica non troppo ricercata amata da sportivi e showgirl. Poi, velocemente come era cresciuto, l’impero crollò a causa degli eccessi e della cattiva amministrazione del suo fondatore.
Nokia
All’inizio degli anni 2000 era l’ azienda leader indiscussa. Il 3310 e il 3330 erano must have. I suoi telefoni erano all’avanguardia: il 7650 è stato il primo cellulare a colori in grado di scattare fotografie e tutti ricordano quando Nokia introdusse Snake, Deep impact, il t9. Una rivoluzione e poi il declino. Mentre Apple e Samsung avevano compreso le potenzialità sociali e non solo funzionali dello smartphone e di device come il touch screen, il brand scandinavo restava concentrato su prodotti di qualità, ma poco appetibili. Alla fine del 2013 Nokia venne acquistato da Microsoft acquistò per 9,5 miliardi di dollari, ma solo due anni dopo l’operazione di rivelò un fallimento. Il mercato continuava a cambiare velocemente e la società finlandese restava indietro. Poi, il miracolo: Hmd Global ha risollevato le sorti di Nokia puntando sull’effetto nostalgia e riproponendo modelli cult in versione aggiornata come l’81010, conosciuto anche come “il telefono di Matrix”.