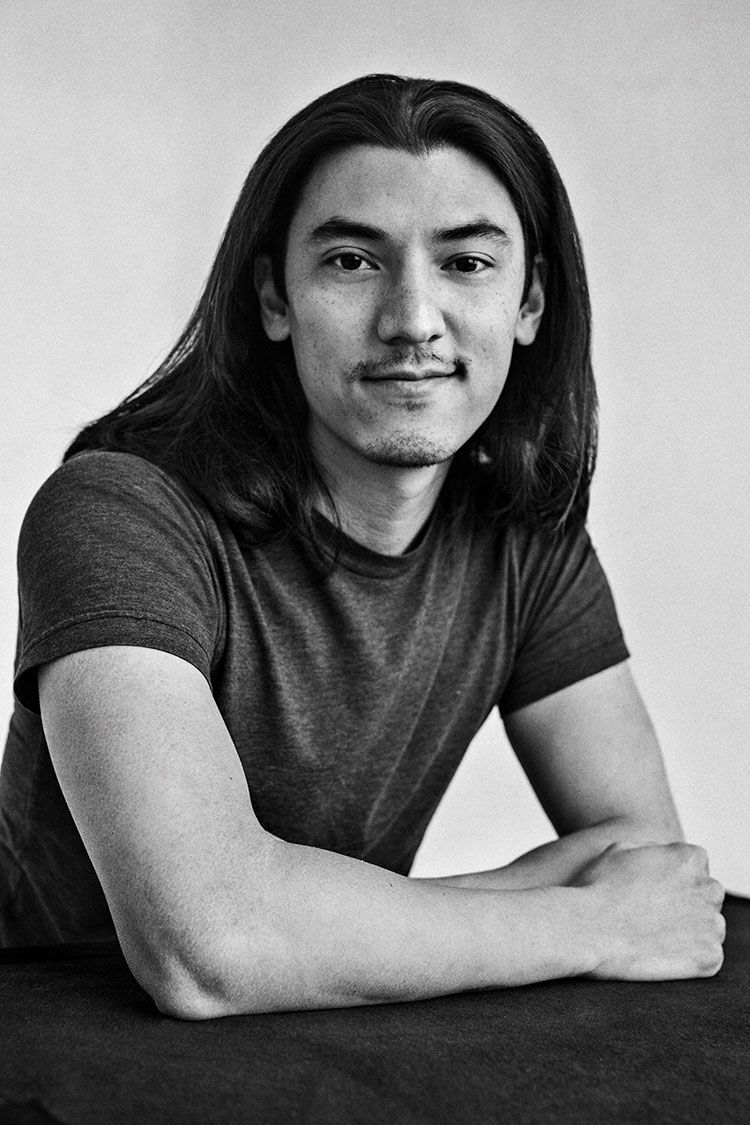Cosa manca in "The Social Dilemma"? Tutte le omissioni e semplificazioni di cui il documentario Netflix non parla
Tra i consigli dell’algoritmo di Netflix in questi giorni c’è The Social Dilemma, un documentario presentato l’anno scorso al Sundance Festival sulle ricadute che la massiccia presenza dei social network ha avuto sulla società contemporanea. Attraverso interviste ad ex-dipendenti e manager di Facebook, Instagram, Google e altre aziende della Silicon Valley (oltre che una piccola dramatization che parla di una famiglia media americana), il regista Jeff Orlowski guida lo spettatore nel lato oscuro dei social network toccando argomenti come la depressione, la dipendenza e la disgregazione sociale causate dall'utilizzo social network.
C’è un certo grado di ironia nel fatto che sia un algoritmo a suggerire un film che denuncia come altri algoritmi stanno causando un danno alla nostra società. Inoltre saranno gli stessi algoritmi rappresentati da Orlowski come degli omini dentro lo smartphone a far sì che questo articolo sia letto da utenti accuratamente profilati dagli stessi algoritmi. Ma insomma, ce ne faremo una ragione, è un mondo complicato. Il documentario di Orlowski è uno dei contenuti più interessanti del catalogo di Netflix ma cade in molti degli errori ricorrenti quando si parla di Silicon Valley, capitalismo e social network.
The Social Dilemma ha il coraggio di immergersi in un argomento sconfinato e complicatissimo per puntare il dito contro le aziende più ricche della storia dell’umanità - le big tech appunto - denunciando come gli algoritmi e le interfacce dei social siano appositamente disegnate per rubare la nostra attenzione, manipolare la percezione della realtà del pubblico e, in ultima analisi, incasinare il sistema democratico. Il documentario si concentra su due aspetti: gli effetti dei social a livello individuale (la depressione, l’ansia sociale e la sostituzione della realtà) e a livello collettivo (le fake news, la polarizzazione politica, le cospirazioni e l’hate speech). I due esempi della fiction all’interno del documentario sono Ben, teenager che prova a disconnettersi per una settimana fallendo per poi cadere in un rabbit hole di polarizzazione politica, ed Isla, undicenne che piange davanti allo specchio perché vede il suo volto senza filtri social.
Le feature come lo scroll infinito e il refresh di contenuti comune a tutti i social network - da TikTok fino a Instagram, passando per LinkedIn e Pinterest - sono meccanismi presi in prestito dal gioco d’azzardo il cui unico obiettivo è monopolizzare l’attenzione di un utente, per poi lentamente monetizzare vendendone i dati al miglior offerente. Il concetto si può riassumere nella famosa massima: “Se non stai pagando per il prodotto, allora sei tu il prodotto". Ma Orlowski sottolinea come la riprogrammazione del comportamento dell’utente sia l’unico vero obiettivo degli algoritmi che gestiscono le push notification, il feed e l'engagement. La dipendenza non è infatti una debolezza degli utenti o un effetto collaterale - nonostante Justin Rosenstein, che fra le altre cose è stato il creatore del like di Facebook, sostenga che l’obiettivo fosse “spreading positivity around the world” - ma il fine ultimo dell’intera operazione. Allo stesso modo, gli algoritmi hanno capito che le fake news e i contenuti più estremi sono drammaticamente più performanti degli altri contenuti, con l’effetto di aver facilitato processi come l’elezione di Trump, il Brexit o altri eventi sociali di cui il film accusa i social network.
But there's another path.
— Justin Rosenstein (@rosenstein) September 9, 2020
Broken tech is a symptom (and accelerant) of a broken society. We have to fix it at the operating system level: putting *the people* in control of Big Tech. (Then, slowly, of our entire political economy.)
Se questi sono i meriti del documentario, c’è un rovescio della medaglia - la metafora usata dallo stesso Orlowski per spiegare il lato oscuro dei social network - abbastanza ingombrante: una visione deterministica della tecnologia. Sarebbe a dire: Orlowski e gli intervistati analizzano le piattaforme social, le feature e anche il rapporto con gli hardware in maniera completamente decontestualizzata, come se quello stesso prodotto non fosse figlio di un contesto socio-economico e soprattutto senza pensare che ogni essere umano e società si relazioni in maniera standardizzata alla tecnologia. Per dirla con altre parole, la maggior parte dei mali provengono dalla tecnologia che, come suggeriscono gli ingegneri della Silicon Valley, gli impiegati più pagati al mondo, sarebbe però anche la soluzione a quegli stessi problemi.
Riprendendo i due livelli di analisi del documentario, molti studiosi di psicologia specializzati nella Persuasion Theory digitale usano lo schema del drive-motivation per capire come l’attenzione di ogni singolo utente viene agganciata dalle piattaforme. Ognuno ha bisogni e motivazioni differenti nell’uso della tecnologia mentre il documentario analizza solo la profilazione e l’operatività di una piattaforma, dando per scontato che i “like” ad esempio siano l’unica motivazione dell’utente. Allo stesso modo farsi tanti selfie non porta necessariamente alla depressione o all’ansia sociale perché il soggetto che scatta è una persona con una storia complessa, prima di essere un utente.
Allo stesso modo The Social Dilemma sorvola uno degli argomenti più interessanti della relazione umana con la tecnologia: la compressione dello spazio/tempo. La comunicazione digitale ha riscritto le regole fisiche che prima regolavano la nostra società (i cicli di notizie o banalmente l’attesa di una lettera) i device portatili ci hanno reso disponibili 24/7. Lo spazio e il tempo digitale sono quindi diventate una dimensione aggiuntiva a quella reale, che ogni persona ha il compito - difficilissimo - di bilanciare con la dimensione del reale. Questo genere di condizione non è solo frutto di una strategia aziendale, ma è uno dei cambiamenti della società su cui nessuno ha veramente il controllo, che chiaramente ha un impatto antropologico estremamente più profondo di qualunque pulsante su un social network.
Ma il punto su cui il documentario perde un po’ della credibilità costruita nell’ora precedente è il rapporto tra social network e democrazia. Orlowski afferma senza mezzi termini che le democrazie in crisi - dagli USA fino al Myanmar passando per Regno Unito, Italia, Spagna, Germania (Germania?) - hanno tutti una sola cosa in comune: i social network. Per spiegare la crisi vengono usati termini molto di moda nel dibattito americano, come “polaraziation” o “filter bubbles” ed “echo chambers” per descrivere il subdolo sistema con cui i social network chiudono certi utenti in una gabbia ideologica costringendoli ad ascoltare opinioni che rinforzano le loro credenze e pian piano li radicalizzano, alterandone la percezione della realtà.
Si tratta di un’analisi superficiale visto che sì i social network hanno modificato i flussi di news e l’agenda politica, ma le ricadute pratiche sui sistemi sociali sono stati completamente diverse a seconda del contesto. Il nesso tra “crisi della democrazia” e nascita dei social network è un modo goffo per evitare di dover entrare in discussioni molto più complesse: dalla demolizione delle identità collettive fino al livello di salari, l’automazione dei posti di lavoro e la crescente diseguaglianza sociale. Per questo motivo diventa pericoloso semplificare il discorso sul rapporto tra democrazia e social network occidentali - ricordiamoci che la Cina ha un internet a se stante in crescita esponenziale - banalizzando una relazione molto più sfaccettata e contorta. Quello che fino adesso la storia ha dimostrato è che i social sono utilissimi strumenti per mobilitare grandi masse di persone - Black Lives Matter è l’ultimo esempio, ma anche le primavere arabe furono organizzate su Twitter - ma che falliscono miseramente nella strutturazione e gestione del potere, altro punto che il documentario non tocca.
The Social Dilemma ha il grande merito di organizzare e presentare temi che spesso rimbalzano nella conversazione pubblica in maniera disordinata e ma più che una domanda presenta il fallimento di una promessa fatto dalla tecnologia all’umanità. Ma nel tranello di puntare il dito contro i giganti della Silicon Valley, rei di aver distrutto l’internet creativo e inclusivo degli zero per metterlo a reddito, ma allo stesso tempo non riesce ad immaginare un futuro fuori dagli schemi creati dalle stesse società e governi che controllano lo spazio digitale, finendo per chiedere ai carnefici una condanna e una soluzione ai loro stessi crimini.