

Esiste una parola in danese usata per rappresentare lo spirito comunitario: samfundssind. Tradotta dal Danish Language Council come “mettere gli interessi comuni prima di quelli individuali”, ma traducibile anche con “spirito comune” o “mentalità sociale”, è stata una delle parole chiave della Danimarca durante la pandemia di Covid-19, tanto da essere citata dal Primo Ministro Mette Frederiksen in uno dei suoi primi discorsi alla nazione. «Questo è esattamente ciò che abbiamo in Danimarca - samfundssind» aveva detto. In realtà, la parola ha radici ben più profonde che si collegano alla forte tradizione di spirito comunitario che da sempre caratterizza il paese e che molto probabilmente ha avuto un ruolo chiave nella rinascita della moda locale. «Per l'industria creativa danese i legami che uniscono il settore della moda sono sempre stati sostenuti da un radicato senso di comunità. Questo non solo per le dimensioni che il panorama della moda ha qui - siamo una piccola nazione, dopotutto! - ma anche per il valore che viene attribuito al sostegno, alla collaborazione e al rispetto reciproco per gli altri e per il mestiere di ciascuno» mi ha detto Cecilie Thorsmark, CEO della Copenhagen Fashion Week e tra i protagonisti dell’ascesa della città danese nell’industria della moda. «La nostra nazione è governata da un senso di uguaglianza tra i suoi cittadini, un sentimento presente soprattutto nella comunità della moda. Nonostante il mondo sia in costante cambiamento, la stabilità che creiamo tra di noi ci conforta. L'unico modo per crescere è collaborare: è così che coltiveremo il nostro futuro.» Complice il peso sempre maggiore di Copenaghen nella geografia delle Fashion Week, negli ultimi anni l’intero movimento scandinavo è uscito dalla sua confort zone: messo da parte il minimalismo che l’aveva reso celebre, la capitale danese si è trasformata nel centro nevralgico di una rinascita possibile grazie all’unicità della città e di chi la abita. In previsione della prossima edizione della Copenhagen Fashion Week, nss magazine ha voluto raccontare questo percorso attraverso tre dei brand che ne fanno parte. Ognuno con le sue unicità e la sua storia personale. Sunflower, (di)vision e A. Roge Hove sono i protagonisti di Portrait: The Copenhagen Issue.
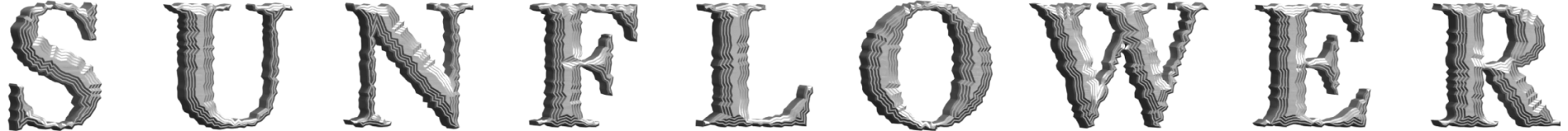
Il quartier generale di Sunflower si trova a Vestergade, in un palazzo nella zona centrale di Copenaghen che condivide con altri brand e aziende. Sempre lì la scorsa estate il founder e direttore creativo Ulrik Pedersen aveva organizzato uno degli show più divertenti della Fashion Week. È con lui e il co-founder Alan Blond che parlo, seduti nello showroom in uno degli ultimi piani dell’edificio. «Abbiamo fondato Sunflower nel 2018 con l’idea di creare un menswear classico ma in chiave contemporanea. Volevamo proporre abiti di qualità ovviamente, ma la cosa che più ci premeva era quella di avere un gruppo di persone che amassero davvero il brand. Una società. La “Sunflower Society”. Il design ricopre un ruolo importante ovviamente, ma quando creiamo un paio di jeans siamo interessati a vedere come verrà indossato dalle persone che fanno parte di questo gruppo.» Con un occhio al minimalismo scandinavo, Sunflower mette al centro la partecipazione collettiva da parte di tutti quelli che amano il brand e la loro capacità di reinterpretarlo in base al proprio stile. «Ci piace vedere come un prodotto anche molto semplice possa essere indossato diversamente da persona a persona. Un maglione nero può essere un ottimo prodotto. Sta a chi lo indossa renderlo unico.» Un’idea, che come racconta Ulrik, non è presente solo negli abiti creati dal brand, ma anche nel modo in cui questi vengono presentati.
«Non creiamo vestiti per gli influncer, creiamo vestiti per persone reali. Anche con i nostri show non cerchiamo di dare la caccia ai “fashion wannabe” ma a tutti coloro che possono arricchire la nostra comunità.» In un momento difficile per i brand indipendenti, avere una community solida alle spalle rappresenta una certezza, soprattutto per un brand giovane. «Sunflower è nato poco prima della pandemia, abbiamo avuto un po’ di tempo per farci conoscere prima che le cose si mettessero male» mi dice Ulrik. «Ma se ti guardi intorno, negli ultimi dieci anni non hanno aperto retailer particolarmente interessanti e questo ha reso tutto più complicato per chi vuole vendere i propri prodotti online. Ecco perché è importante avere una “society”. Certo, un giorno ci piacerebbe aprire un flagship store a Copenaghen, a Berlino o a Milano. Ma va fatto al momento giusto.» Dopo lo show fuori dal calendario ufficiale dello scorso febbraio - «abbiamo mandato la candidatura troppo tardi» mi confida Ulrik ridendo, Sunflower è pronto a tornare all’interno della Copenaghen Fashion Week del prossimo agosto. «Forse quello è stato il nostro show migliore con quasi 400 persone nel nostro studio. Anche se non eravamo nella schedule ufficiale, avere tutta la nostra community presente è stato il successo più grande. Per noi lo show non è un discorso di front row e champagne, ma di posti in piedi e birre. Ecco cos’è Sunflower.» Anche per questo quando chiedo quale sia il ruolo di una città come Copenaghen nel processo di crescita della moda scandinava la risposta di Ulrik e Alan è netta e decisa: «Copenaghen non dovrebbe mai competere con Milano, Parigi, Londra o New York. Perché non è nessuna di queste città e non deve esserlo. Anche noi come brand non dovremmo mai pensare di competere con le realtà che sfilano in quelle città, perché non potremmo farlo. Dobbiamo essere orgogliosi di far parte di Copenaghen provando a incanalarne la bellezza.»
«Non creiamo vestiti per gli influncer, creiamo vestiti per persone reali. Anche con i nostri show non cerchiamo di dare la caccia ai “fashion wannabe” ma a tutti coloro che possono arricchire la nostra comunità.» In un momento difficile per i brand indipendenti, avere una community solida alle spalle rappresenta una certezza, soprattutto per un brand giovane. «Sunflower è nato poco prima della pandemia, abbiamo avuto un po’ di tempo per farci conoscere prima che le cose si mettessero male» mi dice Ulrik. «Ma se ti guardi intorno, negli ultimi dieci anni non hanno aperto retailer particolarmente interessanti e questo ha reso tutto più complicato per chi vuole vendere i propri prodotti online. Ecco perché è importante avere una “society”. Certo, un giorno ci piacerebbe aprire un flagship store a Copenaghen, a Berlino o a Milano. Ma va fatto al momento giusto.» Dopo lo show fuori dal calendario ufficiale dello scorso febbraio - «abbiamo mandato la candidatura troppo tardi» mi confida Ulrik ridendo, Sunflower è pronto a tornare all’interno della Copenaghen Fashion Week del prossimo agosto. «Forse quello è stato il nostro show migliore con quasi 400 persone nel nostro studio. Anche se non eravamo nella schedule ufficiale, avere tutta la nostra community presente è stato il successo più grande. Per noi lo show non è un discorso di front row e champagne, ma di posti in piedi e birre. Ecco cos’è Sunflower.» Anche per questo quando chiedo quale sia il ruolo di una città come Copenaghen nel processo di crescita della moda scandinava la risposta di Ulrik e Alan è netta e decisa: «Copenaghen non dovrebbe mai competere con Milano, Parigi, Londra o New York. Perché non è nessuna di queste città e non deve esserlo. Anche noi come brand non dovremmo mai pensare di competere con le realtà che sfilano in quelle città, perché non potremmo farlo. Dobbiamo essere orgogliosi di far parte di Copenaghen provando a incanalarne la bellezza.»
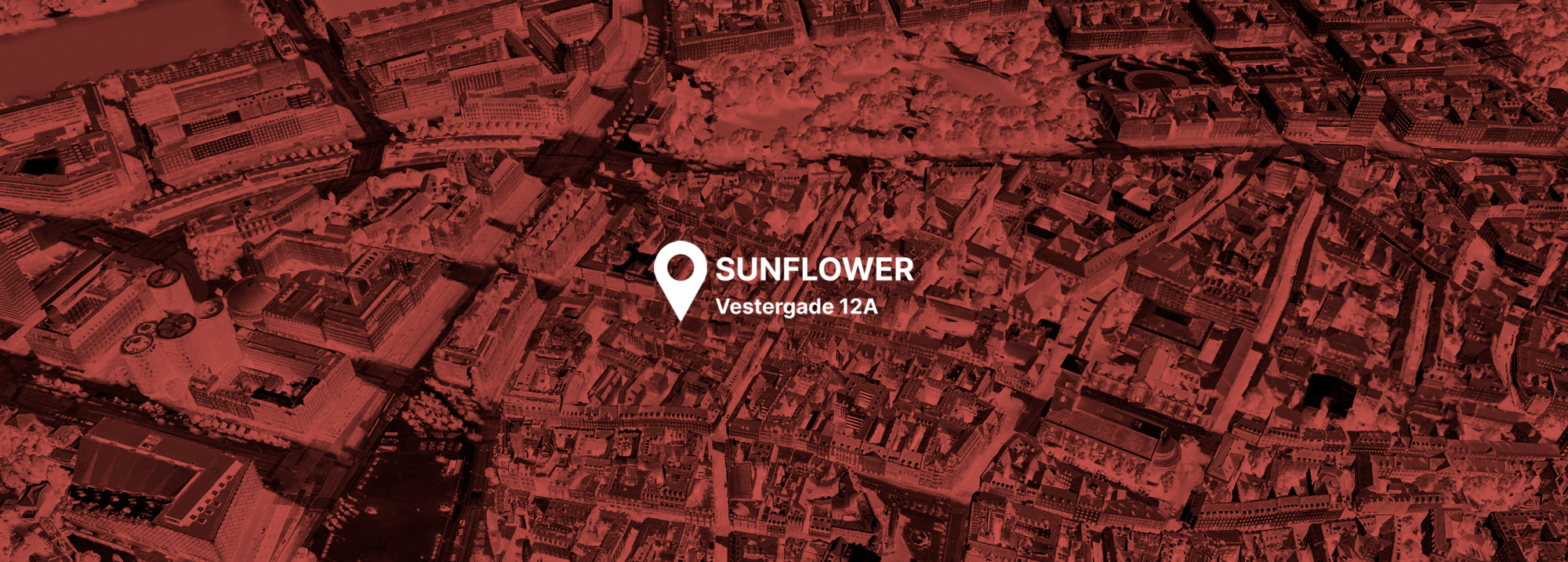

Simon Wick è pieno di tatuaggi, ha i capelli rasati e un cappello che recita “Jesus played the Ocarina”. È quel tipo di persona che ti rimane impressa fin dal primo momento in cui la vedi. Una caratteristica che condivide con il suo brand, (di)vision. Lo scorso agosto Simon e sua sorella Nanna avevano scelto un piccolo bosco vicino all’Hangaren, un ex hangar nell’isola di Refshaleø utilizzato come location per party, per ospitare il loro show a base di citazioni di Apocalypse Now e succo di frutta corretto, mentre a febbraio avevano invaso internet con lo show “Dressed for Disaster”. Per capire come tutto è iniziato, incontro Simon negli uffici di (di)vision a Lavendelstræde, una strada nella parte vecchia della città in cui, all’inizio del 1800, ha vissuto anche Constanze Mozart, vedova del compositore austriaco. «Ho fondato (di)vision insieme a mia sorella circa cinque anni fa con l’idea di fare qualcosa di diverso. Mi sono sempre interessato al concetto di ricostruire e riutilizzare, ma soprattutto a come poterlo incorporare all’interno di un brand. I nostri primi prodotti sono stati alcuni vecchi bomber militari, ma non avendo idea di come si cucisse un abito ho chiesto aiuto a mia sorella.» Da quel momento il brand è cresciuto nel rispetto della stessa idea, creare partendo da qualcosa che già esistesse, adattandola di volta in volta alle necessità: dai materiali di scarto agli eccessi di magazzino, fino all’upcycling e «tutto ciò che c’è nel mezzo» come mi dice Simon. «Adesso siamo un brand ready-to-wear fortemente focalizzato sulla community. Cerchiamo di fare tutto internamente, coinvolgendo i nostri amici. L’idea è quella di una grande famiglia.» A saltare all’occhio quando si parla di (di)vision è la sua estetica disruptive in cui il punk incontra la pop-culture e il Y2K, sicuramente ben lontana da quella che siamo abituati ad associare alla moda scandinava. «Ho sempre visto il nostro lavoro come quello di un outsider della Fashion Week. Qui i brand sono prevalentemente femminili, mentre quelli maschili sono super minimali. Potremmo quasi dire che noi siamo l’alternativa massimalista, qualcosa di diverso rispetto a quello che fanno gli altri. Ma questo non è un aspetto negativo. Mi piace vedere Copenaghen e la moda danese come qualcosa in cui tutti crescono insieme: se noi cresciamo lo fa anche Sunflower e viceversa. Quindi sì, potrei dirti che siamo degli outsider, ma è solamente un vantaggio per noi.»
Dopo il successo del loro ultimo show, (di)vision ha deciso di prendersi una pausa dalle passerelle, scegliendo di dedicare il suo prossimo appuntamento alla community e ai fan. «Oggi sembra che gli show delle Fashion Week debbano essere elitari, mentre le persone che tengono davvero a un brand non hanno la possibilità di partecipare. Capisco che deve essere così, perché è così che funzionano la cose. Ma per questa volta abbiamo voluto capovolgerle. Non ci sarà nessuna nuova collezione, abbiamo preferito spendere i nostri soldi per le persone che ci hanno aiutato negli anni.» La famiglia di (di)vision in effetti è una di quelle numerose. Oltre a Simon, Nanna e l’intero team, il suo trucker hat è diventato la divisa ufficiale della sua community, onnipresente per le strade della città danese e non solo. Tra i suoi fan in giro per il mondo ci sono anche Vittoria Ceretti - «un’amica della mia ragazza» mi confida Simon, Jordan Daniels, 070Shake e Lalisa Manobal per citarne qualcuno. Ma nonostante il successo globale del brand, la sua attenzione rimane sulla città in cui è nato. «Siamo una città più piccola rispetto alle altre capitali della moda, ma questo ci da molta più libertà. Lavorare qui significa avere un’altra prospettiva su cosa puoi fare e cosa non puoi fare con il tuo brand, ma soprattutto significa avere la possibilità di sperimentare. È anche per questo che la moda scandinava sta cambiando. C’è una nuova generazione di designer pronta a mettere in atto le proprie idee. L’importante è non aver paura di farlo.»
Dopo il successo del loro ultimo show, (di)vision ha deciso di prendersi una pausa dalle passerelle, scegliendo di dedicare il suo prossimo appuntamento alla community e ai fan. «Oggi sembra che gli show delle Fashion Week debbano essere elitari, mentre le persone che tengono davvero a un brand non hanno la possibilità di partecipare. Capisco che deve essere così, perché è così che funzionano la cose. Ma per questa volta abbiamo voluto capovolgerle. Non ci sarà nessuna nuova collezione, abbiamo preferito spendere i nostri soldi per le persone che ci hanno aiutato negli anni.» La famiglia di (di)vision in effetti è una di quelle numerose. Oltre a Simon, Nanna e l’intero team, il suo trucker hat è diventato la divisa ufficiale della sua community, onnipresente per le strade della città danese e non solo. Tra i suoi fan in giro per il mondo ci sono anche Vittoria Ceretti - «un’amica della mia ragazza» mi confida Simon, Jordan Daniels, 070Shake e Lalisa Manobal per citarne qualcuno. Ma nonostante il successo globale del brand, la sua attenzione rimane sulla città in cui è nato. «Siamo una città più piccola rispetto alle altre capitali della moda, ma questo ci da molta più libertà. Lavorare qui significa avere un’altra prospettiva su cosa puoi fare e cosa non puoi fare con il tuo brand, ma soprattutto significa avere la possibilità di sperimentare. È anche per questo che la moda scandinava sta cambiando. C’è una nuova generazione di designer pronta a mettere in atto le proprie idee. L’importante è non aver paura di farlo.»

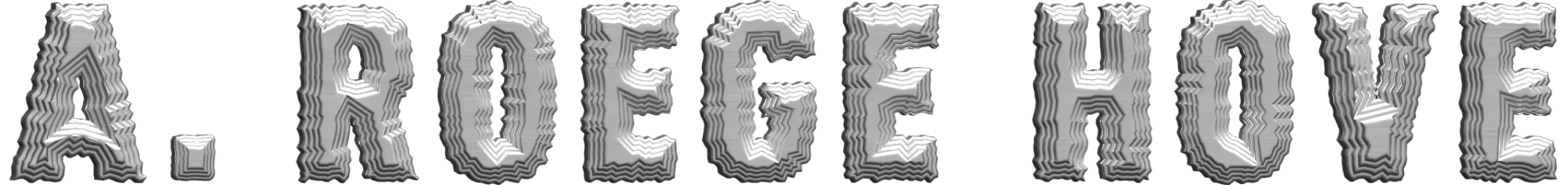
The King’s Garden è uno dei parchi più antichi di tutta la Danimarca. Nato all'inizio del XVII secolo come giardino privato del castello di Rosenborg del re Cristiano IV, il parco è oggi uno degli spazi verdi più famosi e visitati della città danese tanto da essere apparso anche in uno degli episodi della serie The Bear. È lì che Amalie Røge Hove sceglie di incontrarci per parlare del suo brand, A. Roege Hove, a poche settimana dalla vittoria del Karl Lagerfeld Award for Innovation nell’ultima edizione dei Woolmark Prize. «Siamo un brand focalizzato sul knitwear» mi dice subito. «Una scelta che nasce dall’idea di poter sperimentare, di sfidare materiali e forme». Nonostante sia nato solamente pochi anni fa, il brand ha già una sua idea chiara di moda e dei suoi valori - tra cui «non voler provare a fare qualsiasi cosa» dice Amalie - in un processo creativo che parte nei piccolissimi uffici del brand a Copenaghen e arriva fino alle fabbriche divise tra l’Irlanda e l’Italia. A Perugia, per la precisione. Così come gli altri brand intervistati nei giorni precedenti, anche A. Roege Hove può considerarsi giovane. Nato nel 2019, Amalie e il suo team hanno dovuto fare fin da subito i conti con la pandemia e con il suo impatto su una realtà indipendente in un processo di sopravvivenza in cui hanno giocato un ruolo chiave la città e la sua comunità: «Ho vissuto a Londra e a Shangai, ma se dovessi trovare qualcosa di magico su Copenaghen direi la sua onestà. Ammettere senza problemi cos’è che va bene e cos’è che va male. E quando le persone sono sincere tra di loro finiscono per aiutarsi nonostante quello che ti può succedere nei momenti negativi. Puoi parlarne con gli altri, confrontarti e scambiarti consigli. Non è come in molte altre città, in cui tutti sono pieni di segreti. Qui fai parte di una community.»
Quando parla di community Amalie si riferisce prima di tutto al suo team, formato da sei persone più i collaboratori che lavorano ai diversi aspetti del brand. «Per me si tratta di circondarsi di persone che non fanno solamente vestiti. Ci può essere qualcuno che si occupa dei gioielli che usiamo negli shooting o chi crea l’allestimento dello showroom. È un lavoro di squadra in cui ci si ispira a vicenda.» Un lavoro di gruppo che nasce dal rapporto di fiducia reciproca senza la quale, mi dice Amalie, «molti brand non avrebbero nemmeno avuto la possibilità di iniziare». Una realtà più piccola, ma che come un piccolo laboratorio regala la possibilità di sperimentare e lavorare con una pressione minore rispetto a quelle città che fagocitano le realtà emergenti. È questa libertà che sta rendendo possibile il cambiamento di cui Amalie è protagonista. «Quando ero a Londra e a Shangai, tutti finivano per generalizzare pensando che la moda danese fosse solo “clean and functional”. Non sto dicendo che non sia così, ma abbiamo anche una grande tradizione di artigianato e innovazione. Ecco perché questo è il momento perfetto per lavorare affinché la percezione generale della moda scandinava possa cambiare.»
Quando parla di community Amalie si riferisce prima di tutto al suo team, formato da sei persone più i collaboratori che lavorano ai diversi aspetti del brand. «Per me si tratta di circondarsi di persone che non fanno solamente vestiti. Ci può essere qualcuno che si occupa dei gioielli che usiamo negli shooting o chi crea l’allestimento dello showroom. È un lavoro di squadra in cui ci si ispira a vicenda.» Un lavoro di gruppo che nasce dal rapporto di fiducia reciproca senza la quale, mi dice Amalie, «molti brand non avrebbero nemmeno avuto la possibilità di iniziare». Una realtà più piccola, ma che come un piccolo laboratorio regala la possibilità di sperimentare e lavorare con una pressione minore rispetto a quelle città che fagocitano le realtà emergenti. È questa libertà che sta rendendo possibile il cambiamento di cui Amalie è protagonista. «Quando ero a Londra e a Shangai, tutti finivano per generalizzare pensando che la moda danese fosse solo “clean and functional”. Non sto dicendo che non sia così, ma abbiamo anche una grande tradizione di artigianato e innovazione. Ecco perché questo è il momento perfetto per lavorare affinché la percezione generale della moda scandinava possa cambiare.»

CREDITS













.webp)












.webp)









.jpg)


















































