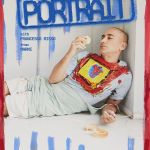La Paris Fashion Week è diventata perbenista?
La moda, questa stagione, è apparsa alquanto borghese
04 Ottobre 2024
Il concetto di “rischio creativo” è stato il più adoperato tra i critici che hanno commentato la Paris Fashion Week conclusasi lo scorso martedì con i giochi pirotecnici di Coperni, forse più luminosi della collezione che hanno accompagnato. Sempre più, il soggetto di ciascuna collezione sembra subordinato alla sua presentazione in una sorta di tendenza alla meta-narratività in cui molti direttori creativi e brand paiono più concentrati sulla continuità e sul contesto del racconto che sul racconto stesso, bloccandosi in un’auto-referenzialità e in certi casi un auto-compiacimento che li ha portati a “fare” se stessi più che a essere se stessi, ad aderire a un’immagine esteriore del proprio stile più che a svilupparlo sinceramente. Osservarsi da fuori significa aver smesso di crescere: come diceva D’Annunzio, «l’anatomia presuppone il cadavere». È stato il caso del già citato Coperni, i cui designer parevano più interessati a creare un “momento” che a innovare gli abiti, ma anche il caso di Rick Owens che, pur rimanendo un venerabile maestro, ha iniziato a sembrare meccanico con la sua ingiustificata fissazione con il Palais de Tokyo, il ritmo glaciale del suo show e la lenta ridondanza di una collezione sempre uguale. Quasi come se stesse iniziando a perdere elasticità e capacità di adattamento, divenendo logorroico, ripetitivo, meno energico. Perché non cambiare location almeno per una volta? A lui e a ad altri avrebbe fatto bene un senso di salutare sintesi, di sveltezza, di salienza.
In effetti, la concisione è stata la caratteristica degli show vincenti della stagione, sia in termini qualitativi che quantitativi. Non parliamo generalmente di minimalismo, anzi, il riduzionismo è addirittura svanito in favore di volumetrie ampie, di un pullulare di pizzi, lingerie e trasparenze; di orli cortissimi o di imponenti abiti sartoriali; di strati accumulati, di cappe, di piume. Ci riferiamo alla capacità di dire ciò che si ha da dire, anche se è poco, in maniera stringata, efficiente, senza mistificare. Guardiamo a The Row e ai suoi ventisette look che magari non rivoluzioneranno il mondo del design ma costituiscono una presentazione agile, diretta ed efficace; guardiamo a Peter Do e alla sua densissima brevità, a Mugler, Noir Kei Ninomiya, Anrealage, Enfants Riches Dèprimès ed Heliot Emil. Tutti brand che si sono limitati a circa trenta uscite a differenza di altri marchi che invece sono andati dai cinquanta look in su spesso diluendo il loro messaggio – ammesso che un messaggio ci fosse. Tanti altri designer, fra cui i più illustri, hanno optato per una tediosa autoindulgenza che lascia presumere sicuramente impegno ma anche la volontà di non mettersi alla prova, la mancata cognizione di essere diventati noiosi. Il risultato sono state collezioni un po’ generiche, dimenticabili, più disposte a seguire le tendenze che a crearne, genuflesse all’algoritmo o che comunque lasciano intendere che i direttori creativi o designer in questione abbiano smesso di porsi domande sul proprio lavoro: ogni creativo che non diventa il più severo, implacabile e spietato giudice di se stesso è condannato a diventare la parodia di se stesso.
@nssmagazine We met Henri Alexander after the latest Enfants Riches Déprimés show: we talked about music, obsessions and what next for the depressed rich kids. #tiktokfashion #fashiontiktok #parisfashionweek #pfw #erd #enfantsrichesdéprimés #enfantsrichesdeprimes #paris original sound - nss magazine
Al di là di casi eccellenti, come quelli di Courregès, Issey Miyake o Yohji Yamamoto, dove era ravvisabile una certa passione o si sentiva comunque la febbrile eccitazione del creare, la sensazione definitiva dopo questo fashion month è che la moda istituzionale sia diventata troppo “safe” per esprimere qualcosa di vero. La presenza di “adulti responsabili” nella figura di CEO, investitiori e comitati in luogo dei mecenati di una volta ha creato una moda svolta con la stessa inerte diligenza e lo stesso ottuso candore di un compitino di scuola, leziosa anche nella trasgressione, eccitante come una revisione contabile – in una parola, borghese. Dov’è finita l’irriverenza di un tempo? Dov’è l’imprevisto, il brivido? È come un ballo della scuola a cui tutti i genitori e insegnanti siano presenti a far da sorveglianti: sicuramente non ci saranno incidenti, ma la festa sarà una noia mortale. Anche le generose quantità di gambe scoperte, i tacchi e le minigonne, i seni nudi che appaiono dalla trasparenza di un vestito non avevano nulla di sensuale, anzi, sembravano il prodotto di un’immaginazione frigida, l’idea del sesso che potrebbe avere chi non ne ha mai fatto. E la stessa cosa non si traduceva nel pubblico i cui membri, quelli almeno liberi di adottare lo styling che preferivano, si sono dimostrati spesso e volentieri più avanzati, in termini di styling e gusto, dei look in passerella, il che ci porta a chiederci chi siano i veri tastemaker della moda se i designer o i loro accoliti e soprattutto se i designer, tra le loro mille pastoie aziendali e commerciali, siano ancora in grado di sintetizzare ed evocare come un tempo il sentimento che è la pietra angolare della moda intera: il desiderio.
Is this a bridal look from Luis de Javier? pic.twitter.com/D6DCOkpnnZ
— justice Kelly (@softlyemerging) September 25, 2024
Non è una questione di nudità – se bastasse quella lo show di Luis de Javier, con le sue scurrili, feticistiche spose-sex doll, avrebbe avuto ragion d’essere e non l’aveva. Guardiamo ad esempio a McQueen: Sean McGirr non sembra avere una chiara idea di cosa renda una donna sexy – vuoi per riserbo, vuoi per disinteresse le fosche banshee da lui evocate erano rigide come suore. Un tipo di sensualità che ai suoi tempi Lee McQueen stabiliva più con il taglio anatomico degli abiti, la vertiginosa discesa degli scolli, la maniera in cui un abito pareva essere sul punto di rivelare qualcosa senza davvero rivelarla mai – non è un caso se anche i suoi show meno riusciti (e qui pensiamo alla collezione SS06 che giocava su un simile tipo di sartoria) evocavano un brivido di erotismo forse aggressivo ma mai degradante, au contraire, liberatorio, celebrativo. È come se tanti designer si fossero bloccati su due modalità di sexyness: del tutto inoffensiva o del tutto offensiva, perbenista o pornografica. Il dettaglio più sottilmente conturbante visto in questa settimana era quella striscia di pelle scoperta sotto l’ombelico dei modelli di Balenciaga, tra una polo corta e un jeans a vita bassa. L’immaginazione dei designer parigini non si è spinta più in là.
A ogni buon conto, la sensazione che si ha è quella di trovarsi di nuovo all’inizio degli anni ’90, con la medesima crisi che si respirava allora, dovuta al progressivo declino di brand storici fossilizzatisi in un modello di business e di comunicazione ormai antiquato. Una stanchezza dovuta senza dubbio al fatto che tutti gli angoli della mappa sono stati esplorati, che tutto è stato già visto e inventato e dunque regna l’impressione di essere arrivati alla fine della storia - ma il problema è anche una cultura aziendale apprensiva, troppo giudiziosa. Anche i designer, francamente, sembrano a corto di idee, ma questo perché troppi sono a lavoro sulle stesse cose – è naturale che si sovrappongano e intercambino tra loro. Ma quando la sabbia è sul fondo della clessidra, basta girare la clessidra: incidentalmente, sono proprio questi i momenti in cui si produce uno strappo, un trauma o una frattura che dà la scossa a un sistema sclerotizzato, troppo grande per crollare in un giorno ma la cui decomposizione è già in parte avviata. Chi ricorda di come Marc Jacobs si fece licenziare dall’elegante Perry Ellis per la sua famosa collezione grunge? Oggi, l’unico motivo per cui ci si ricorda che Perry Ellis esiste è esattamente quel momento di disobbedienza - gli executive in camicia dovrebbero far meglio a ricordarselo.